Il signore di Ballantrae è un nobile dall’animo oscuro
Incarna in una figura sola le psicologie di Jekyll e Hyde
Pietro Citati
"Corriere della Sera", 2 giugno 2014
Come tutte le intelligenze vaste, nitide e vertiginose, quella di Robert Louis Stevenson era attratta dal male assoluto. «Mi sembra — scrisse negli ultimi anni di vita — di essere nato col sentimento di qualcosa di inquietante nascosto nel cuore delle cose, di un male e di un orrore egualmente senza limiti». Con una violenza estrema, egli affrontò il male soprattutto in due libri: scrivendo Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde (1886) e Il signore di Ballantrae (1889). Nel primo caso guardò la tenebra del male: quello che esso ha di deforme, abietto, orribile, odioso, al punto da sottrarsi all’espressione e alla parola, superando qualsiasi limite negativo. Hyde destava una «curiosità piena di ripugnanza»: c’era, in lui, qualcosa di anormale e di contraffatto; qualcosa che colpiva, sorprendeva e rivoltava.
Il caso del Signore di Ballantrae era opposto. Il grande aristocratico scozzese emanava una specie di luce radiosa e abbacinante: emanava un fascino senza limiti; affetto, amore, venerazione, adorazione. Era — racconta l’onesto Mackellar, la voce narrante del libro — «un alto e snello gentiluomo vestito di nero, con la spada al fianco, una mazza da passeggio allacciata al polso. Agitò la mazza verso il capitano Crail in segno di saluto, con un misto di grazia e di beffardaggine, che impresse profondamente quel gesto nella mia memoria… Aveva il viso olivastro, asciutto, ovale, con neri occhi, vigili e penetranti, da uomo combattivo e avvezzo al comando. Un grosso diamante gli brillava all’anulare… Le sue maniere erano di un’affabile garbatezza. Ogni suo atto era così piacevole e di aspetto così nobile che io non riuscivo a meravigliarmi vedendo suo padre e sua cognata sedere attorno alla tavola insieme a lui, con facce radiose. Era un meraviglioso attore, che parlava all’orecchio della signora, con una grazia diabolicamente insinuante». Ed ecco il tocco definitivo. «Vi era in lui tutta la gravità e qualcosa dello splendore di Satana nel Paradiso perduto di Milton».
Questo fascino era soltanto una scintillante facciata. James, signore di Ballantrae, pretendeva di essere un cavaliere, un eroe, il fiore dell’aristocrazia europea del Settecento. Ma chi lo conosceva bene, chi ne seguiva le azioni e ne vedeva il volto segreto, sapeva che egli era avidissimo di denaro e di menzogne. Spargeva sangue attorno a sé con cinica indifferenza: torturava; ed era così intimamente brutale e volgare che rivelò la sua natura profonda quando venne nominato capitano da una banda di corsari. Fingeva di essere un nobile protettore degli afflitti e dei perseguitati: mentre era una spia, che per denaro denunciava i suoi compagni di sventura.
James aveva un fratello minore: Henry, che sembrava modesto e mediocre, quanto egli era demoniacamente accorto ed astuto. Henry aveva il senso del dovere mentre egli ne era privo: leggeva poco, parlava poco, mentre egli era un re della conversazione e della lettura: non aveva finezza: era goffo, quasi brutto, inelegante; soprattutto incapace di ispirare amore e dedizione. Tutti lo sfuggivano: le comari del villaggio lo insultavano per strada: al massimo i buoni avevano pietà di lui, che al contrario avrebbe voluto ricevere amore e tenerezza — la tenerezza quotidiana, che rende lieta la vita.
James odiava ferocemente, selvaggiamente Henry: senza nessuna ragione, perché il fratello lo adorava e venerava come gli altri; lo odiava appunto perché non possedeva né eleganza né fascino; e lo considerava colpevole di tutte le sue sventure, delle quali egli era invece il solo responsabile. Lo scherniva, lo chiamava Giacobbe (mentre lui si paragonava a Esaù): gli dava dell’avaro, dell’idiota, del goffo, del contadino, del marinaio alla taverna, dello zotico, della mignatta; non sopportava la sua ingenuità e la sua innocenza, e la sua bontà premurosa e affettuosa.
Nel torturare il fratello, James possedeva un’astuzia diabolica, sempre più raffinata e sottile, che lo colpiva al cuore, e faceva affondare la sua vita in una infelicità senza misura. Quando viveva insieme a lui con il padre e la cognata, James si rivolgeva al fratello nel modo più gentile e squisito se qualcuno lo ascoltava, ma crudelissimo quando lo incontrava a quattr’occhi. Il vecchio Lord e la Signora erano quotidianamente testimoni di ciò che avveniva: avrebbero potuto giurare in corte di giustizia che Mr. James era un modello di tolleranza e di bonomia, e che invece Mr. Henry era un esempio di gelosia e di ingratitudine. Quando James venne dato per morto, nemmeno allora Mr. Henry poté avere sollievo. Il padre e la moglie si riunivano insieme in segreto, per compiangere lo scomparso, e tenevano lontano il malvagio, l’insensibile Mr. Henry, come se fosse un crudele impostore.
Il grande romanzo precipita all’improvviso verso il suo culmine: la notte del 27 febbraio 1757. È il cuore del freddo, al quale Stevenson si avvicina con lievi tocchi successivi. «Al sopravvenire della notte la caligine si rinchiuse nell’alto; il buio calò da un cielo senz’aria, in un’atmosfera immobile e gelida: notte inclementissima e adatta a strani casi». «Non tirava un alito: un gelo senza vento aveva fermato l’aria; e, mentre avanzavamo al lume delle candele, la tenebra pendeva come una volta sul nostro capo. Non proferimmo parola; né udimmo altro suono tranne lo scricchiolio delle nostre scarpe sul viottolo ghiacciato. Il fremito della notte mi si ghiacciò addosso come un secchio d’acqua, accrescendo nelle mie vene il tremito provocato dal terrore».
Avvicinandosi al cuore del freddo, Henry si trasformò: dopo aver udito una terribile offesa di James, diventò calmo, lucido, determinato, sicuro. Si alzò in piedi lentamente, molto lentamente, avendo l’aria di essere immerso in profondi pensieri. «Che vigliacco!» — disse piano come parlando a sé stesso. Poi, senza fretta e senza speciale violenza, diede un rovescio sulla bocca di James. Mr. James balzò in piedi, come trasfigurato: «Non mi parve mai tanto bello», commentò Mackellar. «Le mani addosso a me, esclamò. Non lo sopporterei da Dio onnipotente». Poi, nel gelo, la rapidissima scena del duello. Henry, completamente trasformato, incalzò il fratello con una furia contenuta e trionfante: finché James, menando il colpo a vuoto, inciampò nel ginocchio del fratello e, prima di potersi riprendere, venne trafitto dalla spada di lui, guizzò per un momento come un verme calpestato e poi giacque immobile al suolo. Mackellar e Henry lo credettero morto.
* * *
Questa scena è il meraviglioso culmine tragico del libro. Poi tutto crolla, sebbene il racconto conservi la sua straordinaria bellezza. Henry ha un lungo e terribile incubo, dal quale esce cambiato, abbandonandosi all’odio per il fratello. Sopporta un «grave scadimento»: subisce la pietà di se stesso, piagnucola, beve; la faccia appare invecchiata, la bocca malinconica, la dentatura scoperta in un perpetuo rictus, l’iride dilatata in un campo bianco iniettato di sangue.
Intanto Mackellar si avvicina al genio del male sconfitto: fa un viaggio con lui attraverso l’Atlantico; talora prova nausea come davanti a un essere immondo, talora ribrezzo, talora una strana ammirazione piena di complicità e di odio. Anche la Geenna, conclude Mackellar, «può avere nobili ardori».
Nell’ultima pagina del romanzo, due lapidi. La prima: «James Durie,/ erede di un titolo scozzese,/ signore delle arti e delle grazie,/ ammirato in Europa, in Asia, in America,/ in guerra e in pace,/ nelle tende dei cacciatori selvaggi/ e nelle cittadelle dei re,/ nonostante i grandi meriti,/ le molte imprese e le dure privazioni,/ qui giace obliato». La seconda: «Henry Durie,/ fratello di lui,/ dopo una vita di immeritati affanni/ coraggiosamente sopportati,/ morì quasi al tempo stesso;/ e dorme nella stessa tomba/ del suo fraterno avversario./ La pietà della moglie/ e di un vecchio servo/ pose questa memoria/ad entrambi».
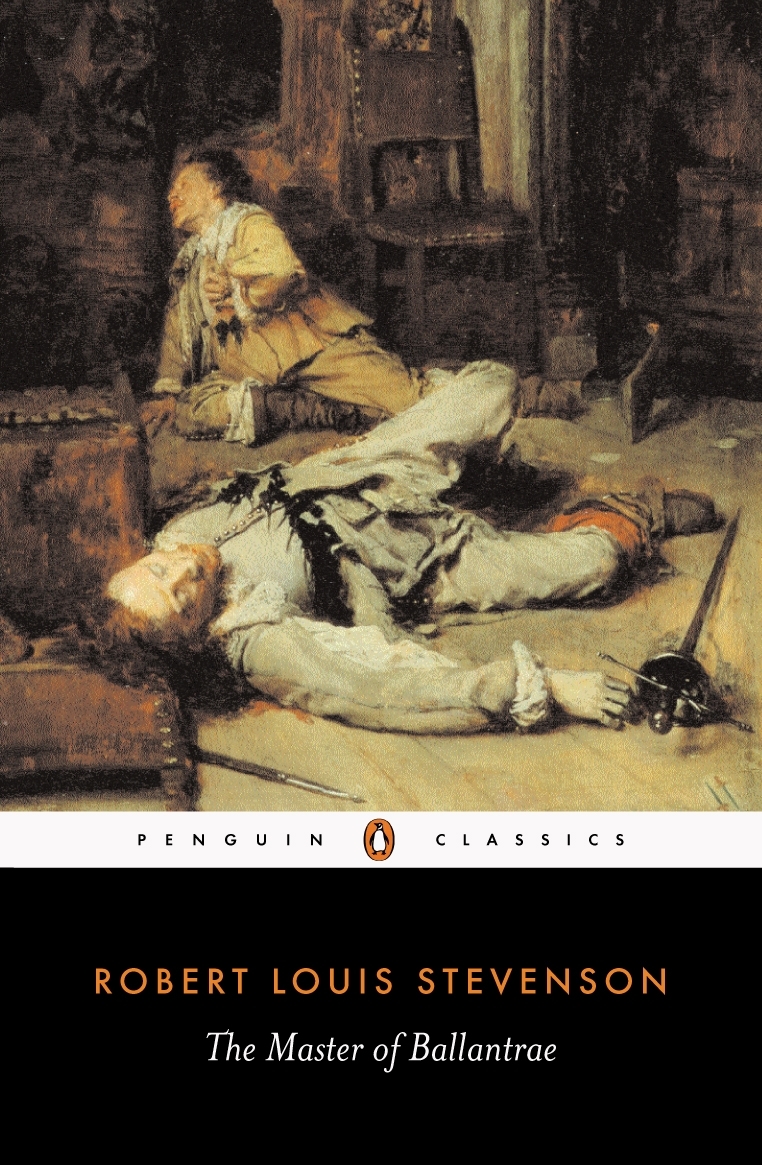
Nessun commento:
Posta un commento